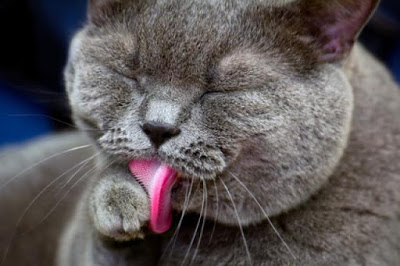L’ipoadrenocorticismo, o Malattia di Addison, del cane e del gatto è una malattia endocrina causata dal malfunzionamento delle ghiandole surrenali.
Le ghiandole surrenali sono due piccole strutture poste in prossimità dei reni. Esse si compongono di una porzione più interna, detta midollare, che secerne catecolamine, e di una più esterna, detta corticale, a sua volta suddivisa in tre strati che procedendo dall’esterno verso l’interno sono la zona glomerulosa, responsabile della produzione di mineralcorticoidi (aldosterone), la zona fascicolata, deputata alla sintesi di glucocorticoidi (cortisolo) e la zona reticolare, nella quale vengono prodotti androgeni.
L’ipoadrenocorticismo è una sindrome conseguente ad un’insufficiente produzione di glucocorticoidi e/o mineralcorticoidi da parte della sostanza corticale delle ghiandole surrenali. Gli ormoni prodotti dalle ghiandole surrenali sono essenziali per la regolazione di molte funzioni corporee come il metabolismo, la pressione sanguigna, l’idratazione e la risposta agli stress.
I glucocorticoidi svolgono un ruolo di vitale importanza perché contrastano gli effetti dello stress, agiscono sui vasi sanguigni e garantiscono una corretta funzionalità e integrità della mucosa gastrointestinale. La carenza di questi ormoni comporta quindi una maggiore sensibilità allo stress, l’incapacità a mantenere il tono vasale, ipoglicemia e debolezza muscolare, sintomi gastroenterici quali riduzione dell’assunzione di cibo fino alla completa anoressia, vomito e diarrea.
La perdita di secrezione dell’aldosterone conduce ad una mancanza di ritenzione renale di sodio e cloro e di escrezione di potassio, con il conseguente sviluppo di carenza di sodio e di cloro ed aumento della concentrazione di potassio.
Le carenze ormonali causate dal Morbo di Addison provocano riduzione della pressione, della perfusione di organi vitali come i reni ed alterazioni nella funzione cardiaca.
Nella maggior parte dei casi l’ipoadrenocorticismo è causato da una distruzione di entrambe le ghiandole surrenali conseguente ad un meccanismo autoimmune, cioè un’alterazione nella risposta del sistema immunitario dell’organismo, e si rende clinicamente manifesta solo quando è interessato più del 90% della corteccia surrenalica.
Altre possibili cause del Morbo di Addison sono l’eccessiva somministrazione di farmaci utilizzati per il trattamento del Morbo di Cushing (la situazione opposta, vale a dire l’eccessiva produzione di cortisolo da parte delle ghiandole surrenali), e la presenza di tumori dell’ipofisi.
L’ipoadrenocorticismo è un disturbo tipico dei cani giovani o di mezza età, ed è stata individuata una predisposizione per il sesso femminile (circa del 70%) e una probabilità tre volte maggiore per i soggetti sterilizzati, sia maschi sia femmine, rispetto ai soggetti interi di contrarre la malattia.
Le razze più frequentemente colpite sono Cane d’acqua Portoghese, Barbone, Leonberger, Alano, Bearded Collie, Rottweiler e West Highland White Terrier.

Diagnosticare la Malattia di Addison non è semplice per diversi motivi: è relativamente poco frequente, i sintomi spesso sono poco chiari e simili a molte altre malattie e compaiono in tempi diversi.
I segni clinici generalmente si presentano in modo graduale, con andamento “altalenante” e sono assolutamente aspecifici. Le caratteristiche che devono mettere in allerta il Medico Veterinario stati di malessere o sintomi gastroenterici episodici ma ricorrenti (letargia, vomito, diarrea e/o disidratazione) che rispondono a semplici terapie di supporto (fluidoterapia, riposo e somministrazione di corticosteroidi). I sintomi più frequentemente riferiti dai proprietari di cani affetti da insufficienza surrenalica sono quelli secondari alla carenza di ormoni glucocorticoidi: anoressia/disoressia, vomito, letargia/depressione, debolezza/astenia, dimagramento, diarrea e tremori, più raramente anche aumento della sete e della produzione di urine e dolore addominale
Nelle fasi iniziali può manifestarsi una sindrome da carenza parziale, caratterizzata da sintomi che si manifestano solo nei periodi di stress quali viaggi, interventi chirugici, ma quando la carenza di sodio e l’eccesso di potassio diventano gravi l’animale può manifestare una crisi addisoniana, un’emergenza medica che richiede l’immediato ricovero in terapia intensiva.
L’ipoadrenocorticismo si può sospettare in base all’anamnesi, ai reperti dell’esame fisico e degli esami del sangue e delle urine. Per confermare la diagnosi è necessario effettuare il test di stimolazione con ACTH, un esame che prevede la misurazione della concentrazione del cortisolo nel sangue prima e dopo la somministrazione di un farmaco per via intramuscolare o endovenosa.
Una volta che la diagnosi di malattia di Addison sia confermata , la soluzione è semplice e consiste nel somministrare all’animale gli ormoni non più prodotti dalle ghiandole surrenali danneggiate. La prognosi in cani e gatti con insufficienza surrenalica di solito è eccellente, ed in seguito alla terapia si noterà un netto miglioramento dello stato di salute del cane che potrà condurre una vita normale e attiva. Non curare la malattia di Addison è molto rischioso per la vita stessa del cane.